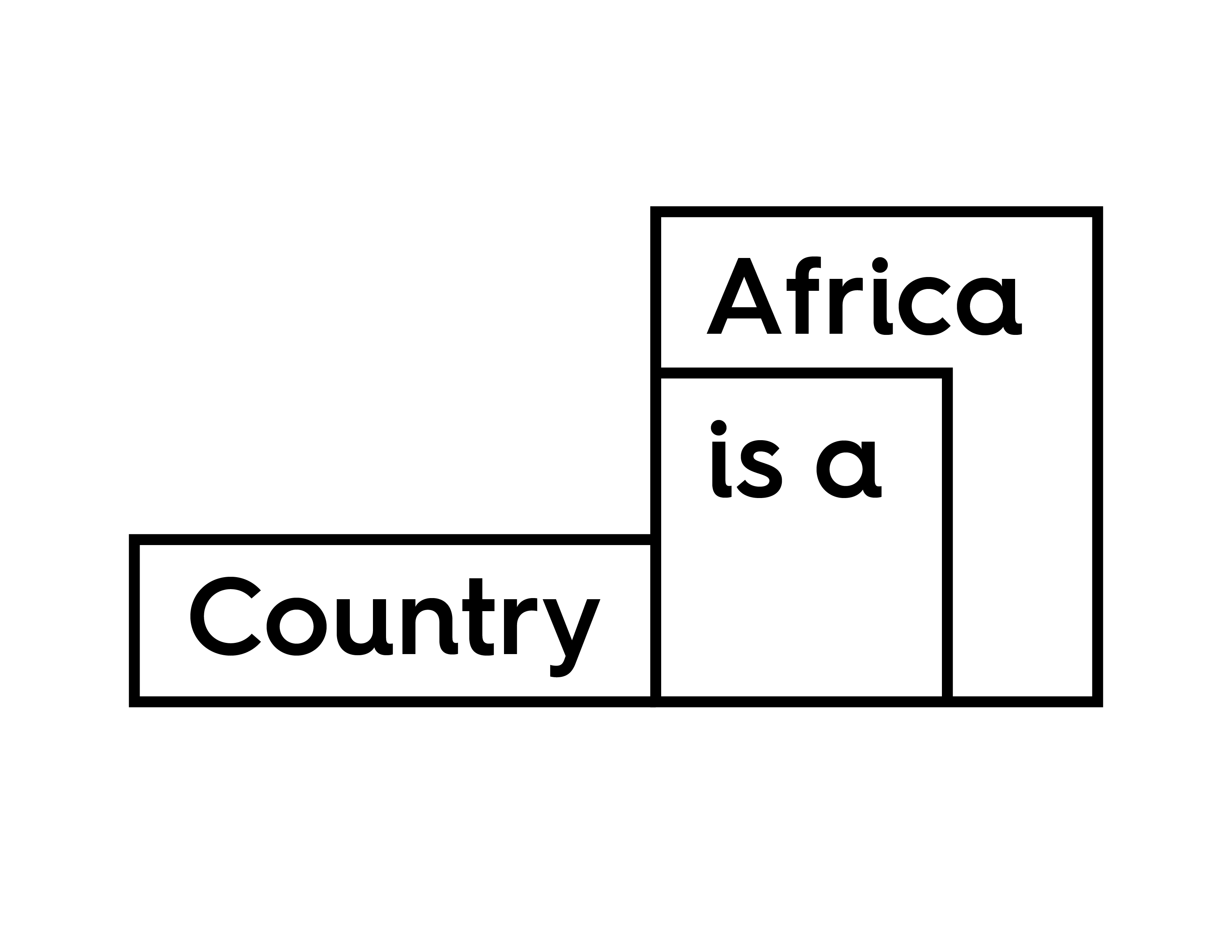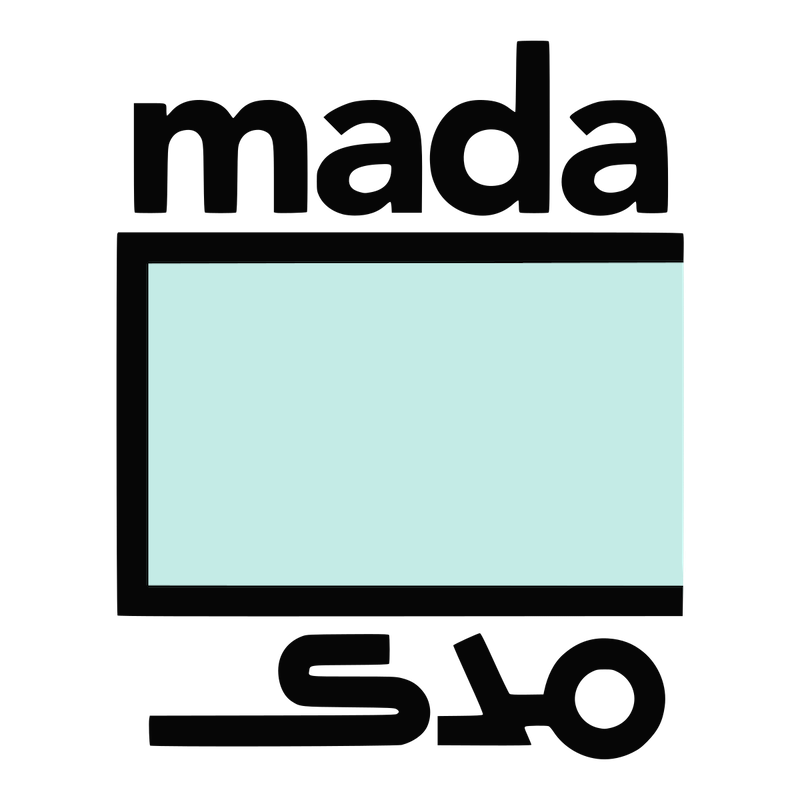Nota editoriale: Quasi due anni fa, l’11 aprile 2019, dopo trent’anni al potere il dittatore sudanese Omar al-Bashir fu rovesciato da un colpo di stato militare. Questo avvenne dopo settimane di continue proteste di strada, raduni e altre forme di disobbedienza civile da parte del popolo sudanese. Il Consiglio Militare di Transizione (CMT) che sostituì al-Bashir includeva alti ufficiali dell’ex regime e resistette alle richieste di un governo di transizione completamente civile. Quando l’11 giugno 2019 gruppi come l’Associazione dei Professionisti Sudanesi, membro dell’Internazionale Progressista, organizzarono un ulteriore raduno di fronte ai quartieri generali militari di Khartoum, i militari risposero uccidendo e violentando centinaia di persone, in quello che divenne noto come “il Massacro di Khartoum”.
Nell’atrio dell’ospedale Al-Moa’lm di Khartoum, ho visto attorno a me morti e feriti. Oltre le spesse porte in vetro, ho visto i veicoli 4x4 delle Forze di Supporto Rapido (Rapid Support Forces, FSR) che trasportavano soldati pesantemente armati e ho sentito il suono dei proiettili.
Nuvole di polvere si sono levate sopra le tende in fiamme, oscurando le settimane in cui sognavamo una vita comunitaria e il carnevale, nella speranza di riuscire in una rivoluzione pacifica.
Ho realizzato quanto la vita possa essere fugace e cosa ci è voluto per restare vivo, per essere in grado di scrivere queste righe: la morte di altri compagni e manifestanti che hanno impedito agli assalitori di entrare nell’ospedale e uccidere altre dozzine di persone, se non centinaia.
La mattina di lunedì 3 giugno 2019, quando il Consiglio Militare di Transizione (CMT) che governava il Sudan ha perpetrato il massacro di Khartoum, a dozzine, me incluso, abbiamo trovato rifugio nell’ospedale. Fuori, più di 150 persone sono state assassinate, molti sono stati gettati nel Nilo e sia uomini che donne sono stati violentati.
Molti sono tuttora dispersi.
Il sit-in è iniziato il 6 aprile al quartier generale dell’esercito, circa 16 settimane dopo l’inizio della rivoluzione popolare contro il regime islamico presieduto dal luogotenente generale Omar al-Bashir. L’11 aprile, sotto pressione dei manifestanti e di alti ufficiali, Bashir si è fatto da parte, ed è stato istituito il cosiddetto Consiglio Militare di Transizione per volere di un gruppo di alti ufficiali del precedente regime, capeggiato dal vicepremier uscente e ministro della difesa.
Quest’ultimo,visto come una diretta continuazione del vecchio regime, si dimise dopo appena un giorno a causa delle proteste incessanti che richiedevano un governo interamente civile per condurre il paese verso elezioni democratiche.
La notte del 2 giugno, sono entrato negli accampamenti alle 10 di sera insieme ad alcuni amici. Ci siamo diretti al nostro solito posto vicino al campus di medicina dell’Università di Khartoum. Nonostante i segnali di avvertimento che il CMT si stava apprestando a disperdere il sit-in, l’atmosfera di carnevalesca libertà e di gioiosa solidarietà ha impedito a me, come a molti altri, di prevedere l’orrore che si sarebbe materializzato.
Quasi all’alba mi sono diretto all’ultima barricata su Nile Street dove ho trovato i giovani riuniti a cantare attorno ad un fuoco, con dozzine di veicoli militari a pochi metri di distanza.
Tornando all’accampamento ho rassicurato i miei amici che un attacco era impossibile.
Meno di un’ora dopo abbiamo udito colpi di arma da fuoco e assistito al caos delle persone che cercavano di scappare.
Una forza armata mista si è riversata da nord verso il sit-in. Sebbene dei testimoni abbiano confermato che i primi a raggiungere il sit-in indossassero delle uniformi blu della polizia, indagini ufficiali sono ancora in corso per accertare l’identità dei gruppi che hanno condotto gli attacchi. La polizia ha negato il proprio coinvolgimento.
Mentre era in corso la dispersione forzata, l’Associazione dei Professionisti Sudanesi (Sudanese Professionals Association, APS), uno dei principali gruppi coinvolti nell’organizzare il sit-in, si è appellata all’esercito sudanese per “adempiere al proprio dovere e difendere i cittadini dalle milizie del CMT”. Ma i soldati di guardia al quartier generale dell’esercito si sono rifiutati di dare riparo nel complesso militare alle persone in fuga. Un amico ed io abbiamo cercato di raggiungere la sua auto ma siamo riusciti ad arrivare solo fino all’ospedale dove i feriti cominciavano ad arrivare. Dopo esserci rifugiati nell’ospedale, quello a cui abbiamo assistito per le successive dieci ore fuori dalle finestre è diventato un incubo.
Fuori i veicoli armati si sono radunati, minacciando di bombardare l’edificio. Dentro le operazioni di salvataggio continuavano.
I cadaveri sono stati isolati in una stanza, i casi gravi sono stati soccorsi in un altro spazio, mentre la sala d’attesa era piena di feriti che il personale ospedaliero cercava di assistere con l’aiuto dei rivoluzionari, tra i quali si potevano contare dottori e infermieri.
La televisione appesa alla parete stava trasmettendo il massacro dei nostri compagni. Il mio telefono ha squillato; era mia sorella che, in uno stato di panico, mi chiedeva se stessi bene. L’ho informata della nostra situazione e le ho chiesto come stessero gli altri.
Ho mandato un messaggio a mia moglie al Cairo per rassicurarla e ho spento il telefono per conservarne la batteria. Mi sono poi adagiato sul pavimento e mi sono addormentato.
Entro la fine della giornata, le Forze di Liberazione e Cambiamento (Forces of Freedom and Chang, FLC), un ampio fronte politico e sindacale, avrebbero dichiarato uno sciopero generale e sollecitato alla disobbedienza civile, oltre a porre fine alle negoziazioni con il regime.
Dal punto di vista della coalizione, il massacro era stato pianificato in anticipo ed eseguito dal regime, che ora veniva soprannominato “Consiglio del Colpo di Stato”. Il FLC ha additato come responsabili del massacro “l’insieme di forze militari sudanesi, milizie Janjaweed (anche note come FSR), le forze di sicurezza nazionale e altre milizie”, oltre che per gli interventi in altre città come En Nahud, Atbara e Port Sudan.
Nel frattempo, il capo del CMT ha rilasciato una dichiarazione, interrompendo le contrattazioni. Ha annunciato un piano di nove mesi, che terminava con le elezioni sotto “supervisione regionale e internazionale”.
Non so per quanto ho dormito ma, una volta sveglio, sono sceso al piano terra. L’ospedale era ancora pieno di feriti, alcuni di loro nel cortile. Il suono dei proiettili era in qualche modo scomparso, ma il fumo stava ancora salendo.
Gli aggressori avevano distrutto l’accampamento. Poco dopo, quando abbiamo osato lasciare l’ospedale, siamo rimasti in strada ad osservare la nostra terra desolata. La scena ricordava le immagini dei villaggi dati alle fiamme nel Darfur anni prima. All’epoca circolava uno slogan rivoluzionario: “Oh, tu arrogante razzista, siamo tutti Darfur!” Ora quello slogan era diventato realtà.
Mentre ero fuori, ho visto un ragazzo di 10 anni e gli ho chiesto come stessero i suoi amici. Mi ha detto che erano al sicuro e poi ha aggiunto: “Ci hanno traditi”. La sua affermazione mi è rimasta impressa nella mente. I politici e i militari non ci hanno mai voluto proteggere, né la comunità politica che stava nascendo nel sit-in. Ai rivoluzionari non mancava lungimiranza politica: fin dall’inizio del sit-in si sono susseguiti tentativi di disperdere la congregazione. Tuttavia questo era un tradimento della nostra fiducia, dell’euforia che l’accampamento rappresentava.
Non pensavamo che qualcuno potesse uccidere un uccellino.
Nel settembre 2019 il Premier del governo di transizione, Abdalla Hamdok, ordinò un'indagine sul massacro, creando una commissione al quale furono concessi tre mesi di tempo, prorogabili una sola volta, per pubblicare il proprio rapporto. Fino ad oggi, 17 mesi dopo, nessun rapporto è stato pubblicato.
Numerosi rapporti hanno stimato il numero dei morti tra 100 e 150, ed i referti medici indicano 70 casi documentati di stupro ai danni di uomini e donne.
Ma nel novembre 2020 un’altra commissione del governo ha scoperto una fossa comune a Khartoum, che fonti forensi hanno collegato al massacro. Questa conteneva circa 800 corpi.
Cosa abbiamo perso nel massacro? Non solo centinaia di vite ma anche l’idea di un Sudan come un bene comune. Da quando la rivoluzione iniziò nel dicembre 2018, rivendicazioni di territori e di confini si sono susseguite, anche intorno al sit-in nelle settimane precedenti al massacro. Dove iniziava il sit-in? Dove finiva la protezione ai manifestanti? C’era un limite che permetteva attività rivoluzionarie solo all’interno dei suoi confini?
Tutte le attività all’esterno dei confini del sit-in erano dunque illegali e vulnerabili agli attacchi delle forze dell’ordine?
Dentro i suoi confini, il sit-in ripensava la mappa mentale del Sudan. Esprimeva l’idea di Sudan che fino ad allora esisteva solo nell’ideologia e nelle fantasie più ottimiste.
Tutto il Sudan era presente e non solo in termini territoriali, nonostante le tende portassero segni di gruppi geografici ed etnici differenti, ma anche in un fluido e carnevalesco sentimento che osteggiava la sottostante finzione cartografica, come una mappa del Sudan disegnata da un bambino.
È stata questa infantile mappa rivoluzionaria - con le sue rappresentazioni, espressioni e il suo potenziale - che ha scatenato la paura e l’ansia nel vecchio regime e ha reso chiara l’impotenza dei partiti tradizionali che avrebbero dovuto guidare il cambiamento. Le negoziazioni sui limiti dell’area del sit-in, disegnati da una commissione di sicurezza congiunta che includeva il regime militare e la coalizione FCC, hanno rappresentato, simbolicamente, le negoziazioni sul destino stesso della nazione.
Quando i rivoluzionari, per ragioni di sicurezza, hanno esteso l’area che includeva le loro barricate, dopo un primo tentativo di dispersione il 13 maggio, sono stati costretti ad arretrare alle posizioni di partenza in seguito ad un conflitto all’interno del SPA, cedendo in segno di resa interi territori della zona riconosciuta come “occupata”.
E quando una di queste aree immediatamente a Nord dell’accampamento, un quartiere povero noto come Colombia, vessato dagli stereotipi negativi di classe e razza, con l’aggiunta di alcolismo e abuso di sostanza stupefacenti, divenne la scusa per un intervento militare, ciò equivaleva al sacrificio del quartiere e dei manifestanti moderati sull’altare della moralità borghese. Infatti, i vari partiti - il CMT, i moderati e i radicali di FFC - avevano mappe differenti che si traducevano in differenti visioni della società sudanese. Finora, è la corrente progressista che ha perso.
La mattina dopo la violenta repressione contro il sit-in, mentre ero ancora nell’ospedale, ho saputo degli eventi sanguinari che si erano diffusi in molte altre città, e dell’occupazione da parte delle FSR delle strade della capitale. L’umiliazione da questi inflitta ai cittadini di Khartoum sarebbe continuata per più di una settimana.
La situazione si è movimentata nuovamente davanti ai cancelli dell’ospedale, con numerose persone assembrate lì fuori. Il personale delle forze armate, accompagnato da pochi civili, si è parcheggiato di fronte all’ingresso.
La loro presenza, abbiamo saputo in seguito, mirava a negoziare un’uscita sicura per i civili intrappolati dentro l’ospedale. L’auto del mio amico è stata completamente distrutta, crivellata dai proiettili e con gli interni vandalizzati.
I soldati impegnati nel negoziare il nostro passaggio sicuro, mi hanno impedito di raggiungere il gruppo che stavano evacuando a causa delle mie treccine, che potevano sembrare una provocazione verso le RSF, data una presunta somiglianza con i militanti del Darfur, e così mi è stato ordinato di tornare dentro l’ospedale.
Ho poi saputo di persone prese di mira proprio per questa ragione.
Il mio corpo e la mia anima sono stati pervasi dallo sfinimento. Sensazione che perdura fino ad oggi: reagiamo in maniera differente quando affrontiamo il trauma di aver scampato la morte, di aver avuto cadaveri chiusi nella stanza a fianco, di aver temuto che il nostro corpo venisse mutilato o ferito.
Molti di coloro che erano là quel giorno sono in cura per disturbo da stress post-traumatico.
Mia cognata, che ha assistito direttamente al massacro, mi ha scritto questo recentemente:
“Il massacro di Khartoum è stato uno dei momenti più difficili della mia vita, essere circondata da tutta questa morte, distruzione e pericolo è molto più di quanto qualcuno possa sopportare. Un momento che non mi piace ricordare ma che non posso dimenticare.
Dopo il massacro, sono tornata in Egitto per iniziare un percorso di psicoterapia. La psichiatra mi ha diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico.
La sua opinione è che dovrei farmi ricoverare due settimane in un ospedale psichiatrico per essere curata e monitorata per le allucinazioni visive e sonore unite a crisi isteriche, ansietà e una costante insonnia. Ho rifiutato il ricovero ma sto continuando con le cure”
Il sit-in era una distanza, tra la rivoluzione e lo stato, necessaria da percorrere. Era uno spazio di euforia dove finiva il vecchio, ed il nuovo poteva essere costruito. La sua dispersione ha rappresentato un punto di rottura in questo processo, o forse lo ha nutrito di nuove idee. Ha certamente chiarito le contraddizioni nell’alleanza politica per il cambiamento, che non solo sono una lezione per capire la storia ma anche per pianificare il futuro.
Le ferite sui nostri corpi rappresentano un’altra mappa: narrano la storia di chi era là e di chi è sopravvissuto.
Amar Jamal è uno scrittore, traduttore e segue un master di secondo livello in antropologia. Fa parte della leva inaugurale di “Africa is a Country Fellows” (Membri di l’Africa è una nazione)
Foto: Africa Is A Country