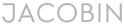morto il bracciante Punjabi Satnam Singh a causa delle gravi ferite riportate in un incidente in un'azienda agricola, e il suo capo non ha fatto nulla per salvarlo. Questo caso sconvolgente ha dimostrato come il settore l’agricoltura italiana consideri la vita dei lavoratori migranti come una merce a basso costo.
Il 19 giugno è stato un giorno di lutto per l'ultima vittima della agromafia italiana. Satnam Singh, migrante di trentuno anni, è morto in un ospedale romano, due giorni dopo essersi tagliato un braccio e fratturato le gambe in un tragico incidente. Singh stava manovrando una macchina agricola in un'azienda nei pressi di Latina, una provincia a circa 70 km a sud di Roma dove le reti criminali sfruttano sistematicamente la manodopera di migliaia di migranti provenienti dal Punjab, in India. Sia Satnam che sua moglie Sony lavoravano nella zona senza contratto dal 2021, piantando meloni per soli 4 euro all'ora. Le azioni del loro capo hanno impedito a Satnam di ricevere cure mediche dopo essersi ferito.
Al momento dell'incidente, Satnam aveva già lavorato dodici ore. Quando la macchina ne ha mutilato il corpo, il padrone (come amano farsi chiamare i datori di lavoro della zona, un termine che ricorda la dipendenza feudale) ha impedito a tutti nella piantagione di chiamare un'ambulanza, confiscandogli i telefoni. Invece di portarli immediatamente in ospedale, cosa che avrebbe potuto salvargli la vita, il padrone ha portato Satnam, privo di sensi, e la moglie, che piangeva disperatamente, nel suo furgone per chilometri e li ha scaricati nel retro della loro casa insieme ai pezzi del braccio mozzato buttati in una cassetta della frutta ed è scappato via. Questo perché, se li avesse portati al pronto soccorso, avrebbe dovuto affrontare le conseguenze giuridiche dell'assunzione dei lavoratori senza contratto e senza protezioni.
La crudeltà delle sue azioni ha suscitato un orrore generale riaccendendo il dibattito pubblico sulla questione del caporalato, una pratica che riguarda la quasi totalità dei lavoratori migranti nell'agricoltura italiana, come è stato ben documentato durante molti anni da ricercatori e attivisti di Latina e non solo. L'attuale dibattito incentrato sulla "lotta alla piaga del caporalato", promosso dai politici del governo in carica e di quelli passati, è stato ribadito durante gli scioperi organizzati dalla CIGL, CISL e UIL di Latina nell'ultima settimana a sostegno di Satnam Singh e di tutti i lavoratori sfruttati. La sindaca di Latina - membro del partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, invitata a parlare sul palco in entrambe le manifestazioni - ha insistito sul fatto che “il caporalato è una forma di schiavitù che non appartiene alla nostra cultura, alla nostra città e alla nostra nazione: come tale, deve essere sradicato”. La sindaca ha ripreso un consueto luogo comune secondo cui gli italiani sono brava gente.
Ma enfatizzare esclusivamente il caporalato può essere fuorviante giacché suggerisce erroneamente che il problema dello sfruttamento del lavoro riguardi solo gli immigrati senza documenti e che sia principalmente opera di alcuni datori di lavoro malvagi e dei loro avidi e spietati intermediari, o “caporali”, che spesso appartengono allo stesso gruppo etnico degli immigrati. Eppure c'è una storia più complessa che si nasconde dietro la questione del caporalato nel mercato del lavoro italiano: è un problema che riguarda l'intero quadro giuridico, politico e culturale, che rende il ricorso ai caporali una scelta quasi inevitabile sia per i datori di lavoro che per i migranti.
Mantenere i lavoratori migranti vulnerabili, divisi e da sfruttare
In Italia, una politica d'immigrazione sempre più selettiva, alimentata dalla propaganda politica sulla “sostituzione etnica” e dalla paura degli stranieri, esige l'impossibile dagli immigrati extra comunitari che intendono lavorare e stabilirsi nel Paese. Queste richieste non fermano di fatto l'immigrazione, ma rendono vulnerabili e sfruttabili coloro che arrivano e restano in Italia, dando un potere sproporzionato a datori di lavoro e intermediari. Questi ultimi hanno imparato a utilizzare i difetti della legislazione italiana per il proprio profitto, sviluppando un business che prospera sullo sfruttamento e la vera e propria frode di migliaia di uomini e donne del Punjab e altri Paesi.
In primo luogo, lo Stato italiano richiede che i potenziali migranti siano sponsorizzati da un datore di lavoro. Quando arrivano, l'acquisizione di un permesso di soggiorno (e, di conseguenza, di uno status giuridico) è vincolata alla stipula di un contratto di lavoro formale con un datore di lavoro. I richiedenti pagano una quota iniziale che varia da 10.000 a 20.000 euro ai caporali che organizzano l'accordo e dividono il denaro con i datori di lavoro locali.
I migranti spesso considerano i caporali come facilitatori e aiutanti e non come trafficanti, come dimostra il termine neutro “agente” utilizzato per riferirsi a questi. Questi “agenti” sono considerati fornitori di un servizio il cui prezzo, come quello di qualsiasi altro servizio, dipende dalle leggi dell’offerta e della domanda e varia quindi anche nel tempo: se quindici anni fa bastavano 5.000 euro per raggiungere l'Europa meridionale (il che rendeva l'Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia accessibili anche ai punjabi più poveri e meno istruiti che qui venivano impiegati per lo più come operai non qualificati, a differenza degli Stati Uniti e del Regno Unito), oggi la tariffa è almeno triplicata. Poiché le condizioni socioeconomiche del Punjab continuano a peggiorare, il desiderio di migrare continua a crescere, nonostante i costi elevati e anche se questo significa richiedere prestiti o vendere dei beni per potersi trasferire. Questo debito, a sua volta, grava pesantemente sui migranti e sulle famiglie che sono rimaste nel Paese di origine, mettendo in dubbio il celebrato ruolo delle rimesse transnazionali per lo sviluppo delle comunità di origine dei migranti.
Una volta che i migrati punjabi raggiungono l'Italia, spesso il contratto di lavoro promesso non viene rilasciato dal datore di lavoro che li sponsorizza, oppure viene richiesto loro altro denaro (di solito tra i 5.000 e i 15.000 euro) per convertire il visto in un vero e proprio permesso di lavoro. Ai nove mesi il visto scade e, se i migranti non sono riusciti a ottenere un contratto regolare, diventano automaticamente “irregolari” (il che, secondo la legge Bossi-Fini del 2002, è punibile come reato e può portare all'espulsione dal Paese). Così entrano in un limbo di assoluta dipendenza e subordinazione ai loro sfruttatori. Oberati dai debiti contratti con gli usurai e con le banche per pagare gli agenti e i caporali, e senza la possibilità di richiedere autonomamente un permesso di soggiorno quando già sono in Italia, sono costretti ad accettare qualsiasi condizione pur di rimanere nel Bel Paese e ripagare i loro prestiti. La loro vulnerabilità, aggravata dalle barriere linguistiche, dall'isolamento nelle campagne, dalla mancanza di sostegno statale per l'integrazione, dall'ignoranza dei loro diritti e da una burocrazia opaca, incomprensibilmente lenta e complicata, impedisce loro di denunciare i loro sfruttatori per paura di ritorsioni violente, di perdere l'unica fonte di reddito, di subire conseguenze legali o di essere espulsi.
In questo modo, la possibilità dei padroni e dei caporali di sfruttare e abusare dei lavoratori migranti è implicita nella legge stessa, indirettamente sostenuta da campagne politiche e culturali volte alla criminalizzazione e alla securitizzazione dell'immigrazione piuttosto che alla tutela dei diritti umani e del lavoro dei migranti. Etichettare il datore di lavoro di Satnam come un mostro (anche se potrebbe esserlo) è una scappatoia facile: incolpare le singole mele marce distoglie sempre l'attenzione dalle forze strutturali che permettono loro di esercitare il proprio potere.
La morte di Satnam non è un incidente dovuto alla “distrazione” di un lavoratore mentre manovrava una macchina o alla crudeltà del suo datore di lavoro. È il risultato di un sistema giuridico, politico e culturale che viola i diritti umani fondamentali, costringere i migranti a lavorare in condizioni di grande sfruttamento, riducendoli a una risorsa usa e getta da buttare una volta esaurita. Nell'Italia di oggi, ci sono forze sistemiche che si intrecciano e che incastrano, mutilano e spezzano i lavoratori migranti, lasciandoli morire, come la macchina e il suo proprietario hanno fatto con il corpo di Satnam.
In qualità di dottoranda che studia la comunità Punjabi nella provincia di Latina, nei tre anni precedenti all'incidente ho intervistato centinaia di uomini e donne nella stessa posizione di Satnam e Sony: sovraccarichi di lavoro, sottopagati, sfruttati, discriminati, privi di documenti. Li ho ascoltati mentre raccontavano le loro storie di abusi, sollevando le loro lamentele, ma anche tanto rassegnati da definire questa situazione “normale”.
Perciò, non è solo il profondo dolore per la morte di Satnam a spingermi a scrivere, ma anche la rabbia, la vergogna e il bisogno di parlare delle innumerevoli ingiustizie che ho visto. È per Jagdish, trentasei anni, che si è rotto un dito al lavoro e il suo capo gli ha detto di mentire in ospedale, dicendo che era successo a casa, se voleva riavere il suo lavoro una volta guarito. È per Balvir, quarantotto anni, che è stato schiacciato sotto un carico di patate al lavoro e scaricato dal proprietario a casa a mezzanotte, dove la moglie e la figlia di dieci anni lo hanno portato in ospedale, guidando attraverso i bui campi pontini. È per Pardeep, ventotto anni, che, lasciando moglie e figli a casa, ha pagato 16.000 euro per venire in Italia e ora vuole tornare in India il prima possibile, perché “qui la gente vuole solo usarti e prendere i tuoi soldi”. Lavora dieci ore al giorno raccogliendo angurie a due euro all'ora; ora il suo visto sta per scadere e il datore di lavoro gli ha chiesto di pagare 5.000 euro per rilasciargli un contratto di lavoro che lo regolarizzerà. È per Daljeet, quarantacinque anni, che si è rotta la schiena lavorando in una coltivazione di funghi dieci anni fa e, dopo aver osato denunciare il fatto, sta ancora aspettando un risarcimento. È per il mio amico Sandeep, venticinque anni, che lavora tredici ore al giorno raccogliendo zucchine, l'unico ragazzo del gruppo senza contratto, quello che lavora di più, il più gentile; il suo capo ieri ha “scherzato” sul fatto che se si farà male come Satnam, lo farà scaricare dai suoi colleghi nel canale che si trova nelle vicinanze. E non era una battuta.
Sovraccarichi di lavoro, sottopagati e senza documenti
Nell'ultimo secolo il Punjab è stato colpito da ripetute crisi economiche, politiche, ambientali e sociali in seguito alla spartizione dell'India dopo l'indipendenza e alla liberalizzazione dell'economia, il che ha spinto un numero crescente di punjabi a emigrare. Secondo un recente studio condotto dalla Punjabi Agricultural University, il 74% di tutta l'emigrazione dal Punjab tra il 1990 e il 2022 ha avuto luogo proprio negli ultimi sei anni di tale periodo. Attualmente il Punjab è al secondo posto tra gli Stati indiani in quanto a tasso di emigrazione. La provincia di Latina, un importante centro di produzione agricola dell'Italia centro-meridionale, è diventata la destinazione più popolare per i migranti punjabi (secondo l'Istat, sette dei primi dieci comuni italiani per numero di residenti indiani registrati si trovano nella provincia di Latina).
Ciò che attrae di Latina è la grande richiesta di manodopera nel settore agricolo e la presenza di una comunità punjabi consolidata dagli anni ‘80. Per massimizzare i profitti e mantenere i costi di produzione sufficientemente bassi da essere competitivi sul mercato dell'UE, il prospero settore agroalimentare della zona (come riportato per la prima volta dal sociologo Marco Omizzolo, uno dei suoi primi e più feroci critici) si affida a una rete internazionale di traffico di esseri umani per fornire una forza sempre rinnovata di lavoratori migranti stagionali da sfruttare nei campi. Questa rete coinvolge datori di lavoro e professionisti italiani, caporali italiani e stranieri, e a volte funzionari corrotti in istituzioni pubbliche.
Molti lavoratori punjabi svolgono lavori manuali pesanti, raccolgono e impacchettano frutta e verdura per dodici o quattordici ore al giorno o anche di più, sei o sette giorni alla settimana, senza alcuna protezione o assicurazione e guadagnando ben al di sotto del minimo vitale. Vengono reclutati tramite un gruppo WhatsApp con un messaggio inviato la sera precedente, indicando l'orario e il luogo nel quale devono recarsi la mattina successiva, pedalando per lunghe e pericolose distanze sulle autostrade. Chi non ha il permesso di soggiorno, come Satnam e Sony, lavora senza contratto. Quelli che ottengono un contratto di solito lo hanno per non più di qualche mese e rimangono quindi esposti ai capricci dei datori di lavoro. Queste condizioni li mettono in una situazione di precarietà strutturale: non solo i datori di lavoro possono pagare stipendi più bassi e mantenerli sottomessi con la minaccia di non stipulare un nuovo contratto (il che metterebbe a repentaglio la loro residenza legale), ma sottoscrivere solo contratti stagionali e di breve durata li esonera dal garantire ai lavoratori l'accesso alle prestazioni sociali, come il congedo retribuito o per malattia, che nessuno di loro riceve mai. Infatti, molti non sanno nemmeno che hanno diritto al pagamento in caso di malattia o di congedo: quando la stagione di raccolta è terminata e il loro contratto scade, si sentono dire semplicemente, “Da domani, sei libero” – una “libertà” che significa che non avranno né lavoro né denaro.
Nella busta paga, le ore di lavoro registrate sono sempre notevolmente inferiori a quelle effettivamente svolte, in modo che il datore di lavoro possa risparmiare sulle tasse mentre i lavoratori ricevono minori contributi pensionistici o sussidi di disoccupazione. Il pagamento avviene spesso a cottimo, anche se i contratti indicano formalmente uno stipendio mensile in linea con il salario negoziato nel CCNL — il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Questa richiesta di produrre di più per guadagnare di più porta spesso all'auto-sfruttamento dei lavoratori e talvolta anche al consumo di droghe, come oppiacei e metanfetamine (con il consenso di medici e farmacie corrotti) per alleviare il dolore del lavoro eccessivo e spingere i loro corpi al di là dei limiti della stanchezza.
Così si forma un esercito di riserva sempre più grande di lavoratori migranti usa e getta e da sfruttare. I suoi soldati sono costretti a rispettare qualsiasi ordine, non importa quanto dannoso sia per loro stessi e per gli altri. La costante disponibilità di personale annulla gli sforzi degli altri lavoratori e dei sindacati per negoziare salari più alti e migliori condizioni di lavoro, impedendo loro di unirsi nella lotta per i loro diritti. Questo sistema capitalistico estrattivo ha un tale potere di divisione che la solidarietà è vanificata persino tra i lavoratori dello stesso villaggio d'origine. Tutti temono il prossimo e la presunta “invidia” di questi: l'altro diventa un concorrente, un nemico, un ostacolo alla propria sopravvivenza. È sconcertante sentire che i colleghi di Satnam hanno esitato a testimoniare per paura di perdere il proprio lavoro. Quale deve essere il livello di disperazione per continuare a volere questo lavoro anche ora che sanno che, se si ferissero, verrebbero lasciati morire nel loro stesso sangue e poi incolpati della propria morte?
I suicidi dei braccianti punjabi, sopraffatti dai debiti e dalla disperazione (come il tristemente noto caso del venticinquenne Joban Singh, che si è tolto la vita nel 2020) evidenziano le devastanti conseguenze di questo sistema criminale di traffico e sfruttamento. Quel suicidio, e la morte di oggi, ci riguarda tutti. Ci coinvolge quando consumiamo il cibo a basso costo in modo non responsabile, prodotto attraverso lo sfruttamento e l'abuso sistemico di uomini e donne che rimangono invisibili e oppressi. Ci coinvolge in un'Italia che sistematicamente non riesce a proteggere i suoi lavoratori più vulnerabili dalle molteplici forze che li strangolano, li dividono e, infine, li uccidono. L’Italia è uno Stato la cui Costituzione proclama “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, ma che non tiene conto degli stessi lavoratori che con le loro cure e il loro lavoro nei campi riproducono la vita stessa.
Annamaria Laudini è antropologa e ricercatrice presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze.